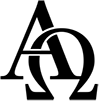Musulmani e cristiani: il punto dopo Abu Dhabi
Ermis Segatti
Don Ermis Segatti insegna Storia del cristianesimo e Teologie extraeuropee presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Sezione di Torino, e svolge attività docente anche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Inizio dalla constatazione che l’incontro di Abu Dhabi, nello spirito con cui è stato condotto, per le parole che ha usato ed anche per lo scopo che si è prefisso, in qualche modo, se si volessero fare dei paragoni, prendendo esempio dall’ambito cattolico, entra nel quadro di quella sorpresa, che venne destata tanto dalla Lettera enciclica di Papa Giovanni XXIII, la Pacem in Terris (11 aprile 1963), quanto, soprattutto, dalla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, documento dedicato al tema de La chiesa nel mondo contemporaneo, promulgata da Papa Paolo VI, il 7 dicembre del 1965, in chiusura del Concilio Vaticano II.
Sorpresa, in che senso? Nel senso, intanto, della lettera di Giovanni XXIII, che aveva un destinatario inconsueto per un documento pontificio, ossia gli uomini di buona volontà.
Naturalmente da questo punto di vista, con un minimo di reminiscenza storica, vengono in mente quali furono le reazioni: “Perché… non è il tuo pubblico, il tuo pubblico è un pubblico di Chiesa, … perché con la Pacem in terris, ti rivolgi agli uomini di buona volontà?” La stessa sorpresa, se vogliamo lo stesso interrogativo, ha avvolto e molto spesso ha anche aggredito, oggi tutto ciò riemerge, il documento della Gaudium et Spes, perché era impostato secondo un’analisi della situazione, condotta col famoso triplice sguardo “vedere-giudicare-agire”, si vedeva la situazione e poi se ne dava un giudizio, prima di impostare un’azione.
Tuttavia, quale situazione? Non la situazione dei credenti, ma la realtà del pianeta Terra di quel tempo, la situazione in generale, da cui si prospettavano delle posizioni dal punto di vista religioso, che erano insomma precedute da uno sguardo laico.
Dunque prima obiezione: questa non è una competenza della chiesa, questa è sociologia. “Perché si fa sociologia? Un Papa deve fare sociologia? Il Papa non è un esperto di analisi del mondo - è esperto, semmai, di conduzione spirituale, rispetto a qualsivoglia epoca storica si rapporti”.
La premessa di quei discorsi, provenienti sia da Giovanni XXIII, che dal Vaticano II, era una premessa, che definirei espressa in termini necessariamente da decodificare, anche proprio sulla base della prima percezione che se ne ha, perché essi non vengano fraintesi: si trattava, infatti, di una prospettiva apocalittica, cioè di svelamento di una condizione urgente ed estrema, rispetto a cui si scoprivano le carte fondamentali, in qualche modo si era costretti ad un confronto con la realtà tutta intera e in una condizione di rischio.
La Pacem in Terris, come si sa, fu scritta in occasione di una possibile guerra nucleare, che aveva in sé una radicalità talmente evidente e disastrosa, da evocare, anche dal punto di vista della tradizione religiosa, una reazione, se così si può dire, uguale e contraria di carattere apocalittico, cioè di chiarificazione del significato ultimo delle cose, che la religione può vedere e offrire.
Anche la Gaudium et Spes, che esprimeva un andamento più sinfonicamente armonioso nel suo stile e nell’insieme, aveva però di fronte a sé l’urgenza di un compito riguardo al pianeta Terra e non solo riguardo ai credenti.
Questa opzione del porre come priorità religiosa, l’umanità in quanto tale e non solo il mondo dei credenti, costituisce il tratto più significativo e in qualche modo provocatorio, anche del documento sulla fratellanza, che è uscito ad Abu Dhabi, un ennesimo tentativo della religione, di porsi in una prospettiva globale rispetto alla realtà, cercando di stimolare l’interlocutore, a ridefinire prima sé stesso, poi il proprio senso della religione e quindi il senso dell’umanità rispetto alla religione.
Si tratta di una prima premessa che volevo porre e che, tutto sommato, non è soltanto una premessa, ma è una questione di sguardo, vale a dire del come devono essere visti questi documenti. Il rischio, infatti, è che essi vengano in qualche maniera, sottovalutati, perché non contengono il discorso immediatamente religioso, non vertono su di una specifica area religiosa, ma riguardano un’area più profonda.
Allora è necessario avere una visione della religione, che tocchi quest’area più profonda, e dell’umanità e dell’uomo, ma se non si possiede questa visione, ci si sente estraniati e si dice: “Questo non mi riguarda - spiego la cosa in termini un po’ sbrigativi - non mi parla di cose di chiesa, piuttosto vado altrove, a sentire una conferenza su questi temi”.
Tuttavia la questione è un’altra ancora, perché si tratta di un atteggiamento proprio del nostro tempo ed è una prima finestra di lettura nei confronti, non solo di questo documento di Abu Dhabi, ma in generale di quei documenti che ho evocato ed anche di altri, come, per esempio, la Laudato si’: perché deve fare ecologia il Papa? La stessa cosa che era stata detta per le precedenti encicliche sociali papali, sia pure in un altro contesto.
Questo comunque è, forse, un segnale provocante, di prima, grande, bellissima risposta religiosa, all’ipotesi secolarizzante e secolarizzata, secondo cui il destino della religione è sparire nella realtà che non è religiosa: la risposta sta nel fatto, che la realtà apparentemente non religiosa, è la più religiosa che mai esista, perché è l’umanità in quanto tale.
Se si pensa che la religione non tocchi quest’area, non si è capito cos’è la religione: eppure una parte del pensiero corrente, è quella che ritiene la religione confinata in un limite, quello della coscienza personale, individuale, oppure del rito, della prassi, della tradizione, sacrali quanto si vuole, ma che rimangano tali e quali, con la religione lì rinchiusa, perché i destini generali dell’umanità si gestiscono invece, “a prescindere” dall’armamentario religioso.
La risposta del documento di Abu Dhabi, come degli altri citati in precedenza, è che, al contrario, quel “a prescindere” non è vero: la religione non può prescindere, da ciò che è profondamente umano, qualunque sia l’ipotesi secolarizzante, che è venuta trionfando o passando come dominante, come ovvia all’interno di un certo tipo di mondo.
Questa, secondo me, è una forma impressionante, se si vuole, che risuona nelle parole come se fosse “soft”, ma in realtà è “hard”, rispetto a quelle ipotesi secondo cui il destino della religione era di sparire nella realtà non religiosa, mentre invece la realtà non religiosa è apparsa essere dominio naturale della religione, quando essa sia il destino finale delle persone, il senso finale dell’esistenza: è questa la vera area e sfera religiosa, non quella che si recita in momenti particolari, in luoghi, storie, gesti e costumi separati.
Nella premessa di cui si diceva prima, sarebbe interessantissimo veder comparire a proposito di un’Enciclica come la Laudato si’ o di un’Enciclica pastorale, considerata un po’ strana, come la Evangelii gaudium, quella frase, che poi si ripete sempre, a volte anche in modo un po’ troppo “tascabile”, declinata come “la chiesa che va fuori” ,... perché la chiesa non è fuori, è dentro, se la si considera fuori, si è in una condizione sbagliata, la chiesa non è fuori dell’umanità, in un luogo separato, ma è dentro.
Tutto ciò lo lascio lì come sfondo, perché è fecondissimo e si presterebbe a tantissime considerazioni sul modo di intendere la religione, un modo che anche noi, nella sua particolarità, abbiamo sviluppato lungo la nostra tradizione storica, specialmente in questa parte del mondo, in cui la tradizione cristiana ha costruito muri, volumi, architetture, culture, che sembravano essere un’espressione compiuta e definitiva del cristianesimo, mentre in realtà erano anche delle mura di cinta, che separavano.
Si tenga conto di questo sfondo, che è fondamentale e al quale noi stessi siamo ancora disabituati, quando stentiamo a riprendere la normalità del discorso religioso, intendendo per normalità la sua congeniale concomitanza con la vita.
Prima di affrontare i temi specifici dell’incontro di Abu Dhabi, dico però alcune cose ancora, che fanno parte di una specie di descrizione del quadro sulla percezione dell’Islam, che correntemente si ha, non solo qui da noi, in questa parte del pianeta, l’Europa, ma, più in generale, che si ha nel mondo, la visione insomma di cosa stia avvenendo nell’Islam e come esso è inteso, non solo a livello dell’immigrazione qui da noi.
Quali impressioni si hanno, dunque? Vi do alcune linee di percezione, che ho colto e che continuo a cogliere, anche e specialmente fuori dall’Europa. La prima è un dato che si rileva da molte parti: è in crescita nel mondo la cosiddetta “rinascita fondamentalista musulmana”.
Per un momento, però, non consideriamo i luoghi in cui ci sono le guerre, perché su quei terreni, quando c’è guerra e soprattutto, quando le guerre sono civili, è difficile discriminare che cosa avviene realmente di caratteristico, riguardo l’insieme di ciò che vi si combatte: se invece ci occupiamo dei paesi, che non sono in condizioni di guerra, ma che sono in condizioni di vita civile, chiamiamola così, normale, è vero che il fondamentalismo musulmano è avanzante, emergente.
Che cosa si intende per “fondamentalismo”? Si intende una specie di rinascita forte dell’identità musulmana e della consapevolezza di essere musulmani nel mondo, dove poi, dentro questo fondamentalismo, si possono manifestare molte cose.
Se voi andate in Indonesia, in Malesia, ed anche in India, se andate in alcuni paesi del Maghreb, nord dell’Africa, o andate in certi altri paesi della Russia asiatica, ex Unione Sovietica asiatica, ma in parte anche in Francia, o in Paesi come la stessa Norvegia e la Svezia, trovate in crescita questo fondamentalismo, il cui significato è l’aver bisogno di riaffermare sé stessi come musulmani. Questo approccio può produrre molte cose, ma va preso come un dato di fatto.
Segnalo alcune espressioni di questa rinascita di consapevolezza: ad esempio, una marcata polemica nei confronti del mondo non musulmano, sempre restando nell’ambito dell’identità, chiamiamola così, religioso-civile, che cela però, dietro questo fondamentalismo montante, una presa di distanza dal modello occidentale; pone una motivazione per differenziarsi anche rispetto all’occidente, visto come diverso, ma in particolare come potenziale nemico dell’Islam, forse, ancor meglio, proprio come pericolo per l’Islam. Questo bisogno di re-identificarsi rispetto a qualcosa, che viene considerato come un pericolo, è piuttosto forte nel mondo.
Altra espressione di consapevolezza, che, sebbene non delinei una mappa tutta omogenea, origina però da tratti che si riscontrano in diverse aree della realtà islamica, è la percezione di profonde lacerazioni e mentre nell’insieme cresce questa coscienza musulmana, permane però il fatto di una irrisolta divisione dell’Islam al proprio interno.
Qui non si tratta soltanto della divisione classica, sia pure durissima, tra sciismo e sunnismo, ma di quella dentro il sunnismo, con l’Islam dell’Arabia Saudita, rispetto all’Islam del Marocco, oppure rispetto all’Indonesia; ci sono poi le lacerazioni tra l’Egitto e altre parti del mondo musulmano, un esempio la Turchia, dove l’Islam viene gestito dalla politica di Erdogan in chiave imperiale e nazionalistica, mirante a restaurare il califfato di Istanbul.
C’è quindi una percezione anche dolorosa, delle divisioni interne, prive della prospettiva di un qualche esito possibile, se non il fatto compiuto, che queste lacerazioni ci sono, sono continue e generano conflitti: l’Islam è anche in guerra al proprio interno.
Questo è un dato che crea problema, proprio mentre si nota, che ciò a cui si trova di fronte l’Islam oggi, prende l’aspetto del confronto con la modernità e con quello che viene visto come nemico, cioè l’Occidente, ritenuto ostile o perlomeno estraneo, ma da cui difendersi: una situazione intricata, dove componenti intellettuali forti, ma minoritarie al suo interno, intravedono nella condizione attuale dell’Islam, un quadro, che sarebbe omologabile e avvicinabile a quello che si è delineato in Occidente, quando deflagrò la riforma protestante.
Rispetto all’assetto tradizionale del Cristianesimo del ‘500, si fa un paragone necessariamente approssimativo, ma utile, per comprendere ed esprimere alcune idee sul fatto che, come alcuni dicono esplicitamente, c’è in gioco una partita durissima, condotta e gestita, rispetto alla maggioranza musulmana, da una minoranza decisa, che concepisce l’Islam, come bisognoso di una riforma profonda e radicale.
Questa riforma profonda e radicale, tocca alcuni nodi fondamentali, come il rapporto con il testo sacro ed anche con quello che, in generale, si chiama la modernità: si pensa una riforma, non in termini di rifiuto e di paura, come accennavo prima, insiti nella componente, che si avverte come fondamentale o fondamentalista, ma piuttosto secondo un atteggiamento di assunzione critica, provocatoria, che intende l’Islam come bisognoso della modernità, sebbene non sia la modernità come l’ha vissuta l’occidente, ma una modernità da Islam, a partire da ciò che è l’Islam.
A questo proposito, ci sono alcune componenti interessanti non solo in Europa, ma specialmente in Africa ed in Asia, le quali, pur essendo ovviamente minoranze, ma in quanto tali, fortemente agguerrite e tenaci, hanno tracciato anche alcuni sentieri per questo tipo di riforma, ossia cosa comporta, cosa richiederebbe, dove dovrebbe sfociare e così via.
Un ultimo aspetto, che fa problema serissimo nell’Islam, è che, in questa fase storica, l’estremismo militante e diciamo violento, è islamico. È un problema certo recente: infatti, mentre prima era delineato più sotto forma di un grande califfo auto-eletto, che diventava la guida ed era l’alternativa dell’Islam, dopo l’attacco alle due Torri Gemelle, oggi il problema è l’estremismo musulmano, diventato invece una nebulosa variabile, fatta di tante componenti.
Il problema della violenza estremista nell’Islam è una preoccupazione fortissima, che viene espressa il più delle volte da coloro che parlano con voi, ma che affrontano l’argomento dicendo: “L’Islam non è estremista!”. È sottointeso che avvertono di essere interpretati da tutti quanti come estremisti, o reali o potenziali.
Adesso entriamo in Abu Dhabi. Se si dovesse dare una prima lettura di carattere molto generale, vi inviterei riprendere i due discorsi, che sono stati fatti prima della firma del "Manifesto sulla Fratellanza", il documento sulla Fratellanza umana, formulato nell’Emirato.
Se si ascoltano i discorsi tenuti da Ahmad Al-Tayyeb e poi dal Papa, noterete una prima cosa abbastanza evidente, cioè che il nervo scoperto al quale fortissimamente ha riferito e ribadito il suo discorso Ahmad Al-Tayyeb, riguarda l’antiterrorismo: l’Islam non è terrorismo, l’Islam è pace. La preoccupazione fondamentale in quel discorso, è proprio stata: “Noi non siamo dei terroristi” e poi naturalmente, quest’affermazione nei documenti è stata declinata: ciò significa che, eccetera, eccetera.
Questa insistenza, direi quasi monotematica, di Ahmad Al-Tayyeb è veramente interessante. Perché interessante? Si osservi che il Gran Mufti di al-Azhar in Egitto al Cairo, rappresentava fino a 20-30 anni fa, forse anche un po’ di più, la grande autorità, largamente riconosciuta, di carattere universale, una specie di, chiamiamola così, implicito magistero pontificio all’interno dell’Islam, nel senso che non solo l’Università del Cairo, come ancora oggi fa, è quella che stabilisce la data esatta del digiuno, pratiche che sembrano essere puramente pragmatiche e rituali, mentre in realtà hanno poi un forte valore simbolico, ma era anche una specie di faro spirituale guida: nell’Islam infatti, essa non si poneva semplicemente come il centro di riferimento pure teologico, per la mediazione tra le varie scuole interpretative del Corano, ma l’università di al-Azhar, ancora oggi prestigiosissima università musulmana, aveva una funzione di riferimento ideale.
Da notare che nel passato, addirittura, era da al-Azhar che venivano le nomine politiche: oggi invece, è avvenuta in modo evidente un’inversione di tendenza, data appunto la situazione di minaccia estremista, così da favorire l’affermarsi in Egitto di una dittatura militare anti-fondamentalismo radicale, per cui in sostanza, al-Azhar dipende ora da questo potere politico, il quale, ribaltando i ruoli, ha preso il sopravvento sul potere religioso.
Si apre qui, lo accenno solo di passaggio, uno dei fronti caldi della forte corrente minoritaria e riformista all’interno dell’Islam, la quale di esso, coglie uno dei nodi irrisolti, rispetto alla modernità, proprio perché l’Islam, fin dalle sue origini, è una società globale, in cui fede e politica non sono distinti: dei punti di separazione non mancano, ma l’ideale è la “umma”, cioè la religione che guida la totalità della società e la società è veramente religiosa, quando è riunita tutta insieme ed anche dal punto di vista politico, riconosce la fede islamica.
Ciò è quanto noi chiameremmo col nostro linguaggio occidentale “teocrazia”, sebbene nella nostra storia non sia stato così, perché, semmai, si è sempre avuta una conflittualità accesa tra le due supreme potestà, da cui è sorta anche la modernità occidentale. Tuttavia all’interno dell’Islam il problema è che fin dall’inizio, non ci sono state due supreme potestà: la potestà è unica, la potestà è quella del Corano, che detta la vita totale, politica, sociale e quant’altro mai.
Quindi la richiesta di riforma da parte di coloro, che vogliono un cambiamento veramente come si deve, all’interno dell’Islam, non è soddisfatta ricacciando la modernità, ma accettando della modernità, quella distinzione, tendenzialmente marcata, tra la sfera religiosa e la sfera politica, impresa molto difficile nell’Islam; basti dire che il re del Marocco è il capo della comunità musulmana marocchina, Erdogan agisce come capo, ma anche al Sisi in Egitto agisce come capo e via discorrendo.
Ora, riprendendo il documento di Abu Dhabi, una prima caratteristica che si nota è una articolata differenza di toni, ma qual è il tono dominante del discorso del Papa, fatto in avvio di incontro e che poi emerge anche nel testo del documento finale?
Direi che se si dovesse trovare una soluzione semplificante, ma anche chiarificatrice di questo “tono”, basterebbe indicare che si tratta dei grandi temi della Laudato si’, solo che qui emergono nel contesto di questo documento. Come?
Provo ad indicarne qualcuno, per averne un’idea più chiara, e a tal proposito accennerò, all’interno del discorso specifico del Papa, a quella che egli ha operato come una specie di riforma delle Encicliche sociali, avvalendosi della Laudato si’, che, di nuovo, emerge nel documento di Abu Dhabi, un documento, intanto, che parte da un’assunzione di responsabilità nei confronti dei problemi fondamentali del mondo, proprio perché deve tener conto della reazione alla secolarizzazione, di cui si è appena detto, da parte dell’ambito religioso, il quale non sparisce nella società, ma vi si rifonda, confrontandosi con la società stessa e con l’umanità.
Quindi la scommessa secondo cui la questione sociale avrebbe spento la religione e la politica avrebbe finito col prevalere, da questo punto di vista, è contraddetta tenacemente: il documento di Abu Dhabi, difatti, inizia con una specie di dichiarazione aperta, su quelli che sono i problemi capaci di angustiare il mondo d’oggi e non si tratta qui di limitarsi a recitare una litania o una cantilena, si tratta invece, di affrontare problemi reali.
Viene in mente un’assonanza con il documento del Vaticano II, la Gaudium et Spes, riguardante la presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo, il cui titolo venne formulato, come si fa per le Encicliche, riferendosi alle prime due o tre parole del testo in latino, considerato l’originale dei documenti pontifici[1].
Anche nella Gaudiun et Spes si fa una specie di panoramica delle condizioni in cui versa la società - si ricordi la breve descrizione che ne ho dato - ed è un testo, pur nella sua dolce e serena sinfonia, di tipo apocalittico, uno showdown.
Allora non solo la povertà, ma le guerre, gli armamenti, le ingiustizie, la corruzione, la disuguaglianza, la discriminazione, tutti temi che torneranno in vita nel documento, anche se, subito dopo aver dichiarato qual è il motivo per cui e su cui si interviene, si offre una nota di stile, che è veramente molto bella, molto importante: si afferma cioè, che il dialogo deve diventare non solo un metodo, ma un criterio.
Molto bello, il dialogo come metodo e come criterio, per affrontare evidentemente queste tipologie di problemi, a partire, ed è ovvio, soprattutto dall’esperienza religiosa: quindi ecco questa “impropria” assunzione di responsabilità, rispetto a ciò che si è enunciato come problema e soprattutto l’appello, composto adoperando la terminologia: “In nome di tutti gli uomini di buona volontà”, che qui riverbera proprio la frase tipica della Lettera enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII, “In nome di tutti gli uomini di buona volontà”.
La Chiesa, la Chiesa cattolica e l’Islam, che improvvisamente parlano in termini pensati non solo per i cristiani, non solo per i musulmani, portano a pensare che sia per l’Islam, come per il Cristianesimo, è l’uomo in quanto tale, che si pone come la base di quello che poi può diventare il credente, ma non il contrario.
Dunque di qui origina anche la volontà di farsi portavoce, rispetto ai poteri presenti nel mondo: la Chiesa, su questo punto, si pone come coscienza critica rispetto alla politica, ma anche i musulmani cercano di farlo, sebbene per loro sia molto, molto più impegnativo.
Ad un certo punto dunque, emerge il tema, che si potrebbe trovare pari pari all’interno dell’ispirazione assunta come guida per formulare la "Laudato si’" di Papa Francesco, perché l’Enciclica Laudato si’ rappresenta, anche per il linguaggio strettamente tradizionale cattolico - riferito alla dottrina sociale della Chiesa, così come alle lettere e alle encicliche sociali - un salto di qualità, che qui emerge da una parola, lavoro, detta con una assoluta chiarezza, proprio al centro del documento (n° 124).
Si sa bene o almeno genericamente, che a partire dall’800, soprattutto la Chiesa ha suscitato delle reazioni. Oggi ci si stupisce delle critiche a Papa Francesco, ma se prendiamo le critiche subite da Papa Leone XIII, quando ha scritto la Rerum novarum, è stato ben peggio! Allora c’era l’avanzata incontrollata della società industriale, nei termini anche di una brutale potenza, basti pensare a cos’erano le fabbriche dell’800.
Quell’enciclica che affrontava la questione sociale sulla base del riconoscimento dei diritti, suscitò reazioni forti, la prima delle quali, concepita da una parte non indifferente di persone eminenti dal punto di vista economico e che poi si professavano cattoliche, è stata: “Cosa gli interessa di queste cose?! Faccia le sue prediche il Papa, che stia in chiesa, cosa guarda a ciò che capita fuori!” E via di seguito.
In ogni caso le encicliche sociali hanno cercato di affrontare, attraverso l’istituzione religiosa, il mondo nelle sue emergenze umane, al tempo in cui crescevano i temi della questione operaia e certamente si sono occupate del problema della proprietà, del rapporto Stato - società civile e di molte altre cose ancora ritenute scottanti, come la lotta di classe o il manifesto di Marx nel 1848.
Dovessi dare una definizione di questa lettera di Abu Dhabi, naturalmente il lettore la prenda con un tocco anche di ironia, la chiamerei “Il manifesto delle religioni”: come c’è stato “Il Manifesto del ‘48” nell’Ottocento, manifesto dei proletari di tutto il mondo, così oggi, credenti di tutto il mondo unitevi, rispetto a … che cosa?
Le encicliche hanno assunto in successione, il carattere di aggiornamento e di aggiustamento, ma sempre all’insegna di una continuità attualizzata. Pio XI ha scritto un’enciclica sociale e in genere questo capitava quando ricorreva il decennale della precedente. La stessa cosa è poi avvenuta anche con Pio XII, che, pur avendo scritto nessuna enciclica sociale, ha però fatto alcuni discorsi sociali alla radio nel ‘41-’42, che sono paragonabili alle encicliche. Giovanni XXIII ha ripreso di nuovo la trafila delle encicliche sociali, per non dire di Paolo VI, la cui Populorum progressio è un esempio classico di aggiornamento sulla base delle emergenze del tempo, che allora, in quel caso, era non la globalità, ma il progresso nell’era della mondialità.
Poi Giovanni Paolo II ha scritto ben tre encicliche sociali. La prima, forse quella più pungente, è la Laborem Exercens del ‘79, dove si dice in quella famosa introduzione: ”Se io scrivo questa lettera, non è per fare ciò che hanno fatto tutti gli altri Pontefici…” In effetti non è stata proposta per ripetere quello che hanno detto tutti gli altri, perché, per tradizione, le encicliche sociali, facevano semplicemente il riassunto di quelle precedenti e poi comunicavano ciò che di innovativo dovevano dire.
Non è per ripetere dunque, ma per affermare quello che “forse”, precisa Giovanni Paolo II, non è stato detto finora: di cosa si tratta? Lo si trova ben espresso al termine dell’introduzione: “Il lavoro è il centro della questione sociale”.
È vero, nessuna enciclica l’aveva riportato, ma chi ha affermato questo principio? Lo ha fatto Marx, solo che il Papa aggiunge: “se teniamo conto della persona umana”, cosa che Marx non ha detto, in quanto lo specifico del pensiero marxiano, se si vuole, è proprio l’aver posto il lavoro anche al centro della riflessione filosofica.
Tutto questo va sottolineato e ripetuto, perché ormai sono cose lontane e non ci si pensa più, ma allora erano cose enormi. Bisogna infatti pensare che nell’unica Università Cattolica libera nei paesi dell’Est, Giovanni Paolo II, avanti l'esser Papa, come professore prima, poi come arcivescovo Cardinale di Cracovia, insegnava etica e con un gruppo di intellettuali di quell’università si poneva una domanda, che destava l’ira o l’ironia dei colleghi, anche credenti cattolici: “Ma cosa studia! Sappiamo noi cos’è il socialismo!” “Cosa perdete tempo su queste domande!”
Wojtiła con il suo gruppo infatti, studiava e cercava di rispondere alla domanda sul perché la teoria, che loro sapevano aver commesso degli errori storici strepitosi, e la realtà del socialismo, che conoscevano bene per ciò che era concretamente e non per come immaginavano gli idealisti in occidente, avessero avuto un successo così impressionante nella storia dell’umanità, con miliardi di persone che vi hanno giocato la loro esistenza.
Questo gruppo di studiosi si impegnava con responsabilità ed infine aveva dato la sua risposta: il grande successo era stato possibile, perché il marxismo aveva portato per la prima volta nella storia dell’intelletto umano, il lavoro al centro della riflessione filosofica e lo aveva fatto considerare degno di pensiero, mentre fino a quel momento si sapeva benissimo che anche la sola parola lavoro era negativa; infatti labora in latino, vuol dire “mi fa male”, così come travail in piemontese e in francese, deriva da “tripalium”, la tortura dei tre pali, mentre in russo rabota, lavoro, è roba da schiavi (ra) e si pensava che era libero solo colui che non doveva lavorare.
Si pensi sia a queste cose, “Il lavoro è il centro della questione sociale”, scritte da Papa Giovanni Paolo II, che ha poi prodotto ancora altre encicliche, sia a Papa Benedetto XVI, che ha composto qualcosa di continuativo con quanto proposto dai predecessori, sia, infine, alla Laudato si’ di Papa Francesco, che esplicitamente interrompe le encicliche sociali: il fatto è che anche lui parla del lavoro, ma ne parla non più come il centro della lettura che egli ne fa, poiché il Papa ha introdotto un orizzonte nuovo nelle encicliche ex sociali.
Qual è l’orizzonte nuovo? È la vita, è il problema della sopravvivenza e della vita, perché addirittura rispetto a questo, il lavoro che l’uomo fa può essere nemico. Il centro ormai, è la vita, rispetto a come è diventato il lavoro nel nostro mondo, un lavoro soprattutto ad altissima tecnologia, del quale la Terra sembra essere più vittima che non strumento.
Allora il Papa nella Laudato sì’, ponendo al primo posto la vita, ha rovesciato il tipo di centralità delle encicliche sociali, appunto per far posto ad un’emergenza che questa enciclica sottolinea non essere più la questione sociale, bensì la questione principale della salvezza del pianeta, entro cui si deve guardare anche alla questione sociale, sebbene non sia più essa, che da sola basta a salvare il pianeta.
Se l’uomo salva soltanto sé stesso ed il suo lavoro, il pianeta può andare in malora: il centro della dichiarazione di Abu Dhabi pone proprio l’affermazione che “la vita è minacciata” e questa è una delle ragioni per cui si fa quell’appello, in nome e verso i responsabili dell’umanità.
Poi però, sbilanciando un poco queste due personalità, protagoniste dell’incontro ad Abu Dhabi, emerge anche che siamo di fronte all’estremismo religioso, a proposito del quale, esse dicono una cosa che, mi sembra, è una delle affermazioni più problematiche, su cui varrebbe davvero la pena discutere, in quanto è più una dichiarazione di principio e di intenti, che non un dato di fatto.
Viene infatti scritto, al centro del loro documento, dopo la dichiarazione sulla tutela della vita, che “Le religioni non incitano mai alla guerra, né a sentimenti di odio, ostilità, estremismo, violenza”.
Naturalmente, dicono, le religioni fanno bene, rispondono bene alla loro natura, ma la frase più giusta forse sarebbe stata, e mi permetto di fare un’osservazione critica, che le religioni devono essere ben attente a non servire per incitare alla guerra, alla violenza, al terrore, ma debbono aprire gli occhi, perché una delle cose che si possono strumentalizzare per affermare l’odio e la violenza, è proprio la religione.
D’altra parte gli estensori del documento, dicendo questo, sottintendono che loro, dall’interno della tradizione religiosa, fanno sì che non si possa mai usare la religione per gli scopi della violenza: tuttavia, come affermazione lapidaria in sé, non è del tutto corretta, perché proprio una delle caratteristiche dell’estremismo che si dice religioso, è di richiamarsi alla religione e di non far finta di credere, ma di crederci. Questo è il punto.
Allora qui emerge, mi permetto, l’unico snodo difficile, mentre per il resto il documento è facilmente comprensibile, perché dà degli indirizzi, orientati secondo la linea prima indicata e cioè: no all’uso della violenza in nome della fede, men che meno il terrorismo, non usare la fede per togliere la libertà, avvalersi della fede affinché si incontrino le culture, specialmente, si dice, quelle d’Oriente e d’Occidente. Purtroppo rimane un po’ esclusa l’Africa dall’orizzonte, perché essa resta sempre un oggetto tendenzialmente indefinibile; poi la donna, la questione femminile, i bambini.
Dunque mi permetto, dal punto di vista dell’estremismo, di affrontare la questione e mi metterei questa volta non dalla prospettiva cristiana, perché il Cristianesimo, proprio per quello che è successo nella storia - ed è un fatto che non si può né dimenticare né contraffare - è stato usato per compiere violenza e questo non si può negare; si può magari criticare, che è un’altra cosa, ma non si può dire che non sia stato così, sebbene non si possa affermare che il Cristianesimo sia solo violenza: questa sarebbe solo una generalizzazione.
Alla fine, quelle che sembrano essere forme di critica estrema, sono piuttosto di insipienza critica e contribuiscono solo al peggio, perché se tutto è così ben definito e si pronunciano affermazioni gratuite, tanto per dire qualcosa, si compie un esercizio vocale che serve a nulla, è una deresponsabilizzazione, dunque decisamente meglio il silenzio.
Invece è molto importante e molto bello, prendere atto di come e dove è potuto capitare, che il Cristianesimo sia stato usato per esercitare violenza, in modo da evitare che ancora si ripeta la cosa: semplificando al massimo, è magari successo quando il Cristianesimo si è associato a vari livelli e a varie forme di potere e quindi la sua Verità di Annuncio è franata in quella conseguenza, che sembrerebbe esser soave, mentre invece è terribile, secondo cui chi possiede la verità, chi sta dalla parte della verità, ha dunque il diritto di imporla, aggiungendo, e qui sta veramente il guaio, con ogni mezzo.
Questo è uno dei ragionamenti più correnti: siccome la verità è la cosa più importante che mai esista, va difesa ed imposta con qualunque mezzo.
Non voglio comunque trattare questo tema, come dicevo prima, perché il Cristianesimo, anche nei momenti più duri della sua storia, può affermare di non essere tutta violenza, in quanto ha dalla sua, una realtà inconfutabile, che è lì presente da sempre come un pungolo, qualunque cosa capiti: si tratta del fatto che Gesù il Cristo è stato ammazzato, con violenza, per motivi precisamente religiosi e non ha risposto, non ha chiesto di rispondere con altrettanta violenza, a quanto ha subìto.
Qui però, entriamo in un discorso che riguarda anche l’Islam: coloro i quali percorrono un cammino di riforma dell’islamismo, sanno che su questa cosa non si scherza, non si citano solo dei versetti a casaccio, qui si affronta un ragionamento importante, che riguarda precisamente il modo con cui si interpreta e si vede la morte di Cristo in croce, da parte del Corano e vale veramente la pena di dedicargli un momento di attenta riflessione.
Ci vorrebbe diverso tempo, ma almeno questo vorrei citare: siamo nella Sura quarta, la Sura delle donne, che è lunghissima e richiede diverso tempo per leggerla tutta e meditarla, viste le tantissime cose che contiene, non solo sulla questione femminile[2].
Nel contesto di questa Sura quarta, versetto 120-130 e seguenti, (ricordo che il Corano, nella tradizione musulmana, è parola diretta di Dio in arabo, che si manifesta anche nel linguaggio, quando i vari versetti iniziano appunto con l’imperativo, di’, fa’, ecc.), si sta polemizzando, si attacca il comportamento degli ebrei per questa o per quell’altra ragione e ad un certo punto al versetto 156, si legge: “Per avere essi detto: in verità noi uccidemmo il Messia Gesù, figlio di Maria, l’apostolo, mentre non l’hanno ucciso, né l’hanno Crocifisso, bensì la cosa fu resa dubbia ad essi; invero quelli che sono di altro avviso intorno a ciò, sono in dubbio a tale riguardo. Essi non hanno alcuna conoscenza riguardo a ciò, ma solo seguono un’opinione, non l’hanno ucciso in verità, bensì Dio lo elevò a sé, perché Dio è potente e santo”.
Cosa si dice in questo versetto? Si afferma testualmente, come non sia vero che gli ebrei abbiano veramente ammazzato Gesù Cristo. “E sbagliano gli ebrei - Dio li rimprovera - voi sbagliate a voler dire che lo avete ammazzato. Voi non lo avete ammazzato, perché Dio è potente, lo ha elevato, lo ha sottratto, lo ha portato fuori dal vostro potere”.
Di qui viene tutta la tradizione dei commentatori musulmani, per cui si diceva: “Allora cosa è capitato? Che Dio con tutta la sua onnipotenza, ha sostituito Gesù con un’altra persona, per cui credevano di aver ammazzato Gesù, ma veramente non avevano ammazzato nulla. Di fatto Dio è potente e saggio e Gesù è stato sottratto alla crocifissione, non è stato ammazzato”.
Qui emergono diversi spunti: il primo è che il profeta non può essere sconfitto, invece Gesù ha proprio insegnato una visione di Dio, che passa attraverso la sua sconfitta, mentre al contrario Dio deve vincere, ad ogni costo!
Quindi la negazione della crocifissione di Gesù, che sarebbe stata una illusione operata da Dio, non si pone più come un fatto storico e reale, ma diviene parte di quel problema interno, fondamentale per l’Islam, che riguarda, invece, il suo sorgere da una conquista, comprensibile secondo l’Antico Testamento, dove, ad esempio, Mosè era un condottiero, perché la visione dell’Islam è una visione di vittoria, generata dal Dio della vittoria.
Questo dà da pensare a parecchi musulmani, perché l’uso che i terroristi fanno di alcuni versetti, che sono versetti di guerra, e all’interno del Corano ce n’è un’infinità, consente a coloro che vogliono porsi in quell’ottica violenta, di esser sempre giustificati.
Per chi invece si orienta ad una religione critica, chiedendosi cosa si può affermare oggi, ecco l’acquisizione della prospettiva modernista dentro l’Islam: ciò significa affermare che ci sono alcune condizioni espresse nel Corano, dipendenti dall’interpretazione, proprio come osservavano certe componenti dell’Islam, fino dai primi secoli dopo la fondazione, ma il dibattito critico dentro l’Islam è stato poi troncato violentemente e non si è più potuto discutere.
Anche l'odierno commento corrente sul Testo sacro, dice che è stato spiegato direttamente da Dio in arabo, ma in realtà, non è così come lo si vuol intendere, si tratta, in effetti, del Corano secondo Muhammad e se anche si afferma il contrario, è invece, proprio secondo Muhammad: ci sono infatti, condizionamenti storici fortissimi e numerosi, che si possono trovare ed evidenziare nei versetti.
Si prenda il Primo Testamento: c’è tanta violenza anche lì, perché è la storia di un popolo, che, al contrario di come siamo abituati a pensare oggi, viveva in condizioni di guerra pressoché continua. Lo stesso vale, e qui la Sura delle donne è un documento fondamentale per discutere dell’argomento, riguardo la condizione femminile, quando chiaramente la donna è trattata, dal punto di vista religioso, al pari dell’uomo: questo è fuori dubbio nel Corano, ma nella vita civile la donna vale metà, per dirla in modo molto spiccio, la sua testimonianza deve essere confermata due volte e un uomo resta un uomo, non c’è parità.
Il discorso sulla donna, se lo si mette sul piano intoccabile della parola di Dio inviolabile, finisce lì, non se ne parla, è scritto: questo è il ragionamento che fa l’estremismo letteralista, magari terrorista, perché può anche esserci un estremismo letteralista non terrorista, ma il terrorismo estremista si basa sul letteralismo.
Invece i riformatori dicono che se si guarda, ed è vero, cosa dice il Corano a proposito della Sura quarta, ma anche altrove, si vede che la donna è trattata come metà, però ha i suoi diritti. Sarà meno del figlio maggiore, ma avrà la sua parte definita di eredità, di dote, la sua possibilità di esprimersi, di agire e via dicendo.
Allora qual è il ragionamento dei riformatori? È molto semplice, dicono che se Muhammad ha indicato queste cose, rispetto al mondo in cui viveva e dove la donna valeva niente, oggi, per coerenza, si deve compiere un passaggio creativo, rispetto a quello che lui aveva fatto nel suo tempo. Quindi se lui ha portato la donna da zero a metà, noi dobbiamo portarla da metà a uno: ecco il ragionamento che fanno, è il ragionamento analogico, il procedere insomma, per analogia.
Il pericoloso pensiero estremista terroristico, che si associa molto bene all’uso della violenza senza limiti, per l’affermazione della verità superiore, e che non ha bisogno di sanzioni morali, afferma che così è scritto, così rimane e non se ne parla più, mentre invece, dicono i riformatori, è scritto così, ragioniamoci su.
L’obiezione dei letteralisti radicali musulmani, rispetto a coloro che ragionano per analogia, qual è? È una posizione se si vuole, tremenda: se ti metti a ragionare così, ti metti all’altezza di Dio, invece devi accettare acriticamente il Dio comune e non se ne parla più.
Ho semplificato al massimo, ma per dire che la posta in gioco è piuttosto seria e lo sanno molto bene i musulmani, che sono le prime vittime del loro stesso terrorismo: è un’osservazione che facevo all’inizio, tutta ben fondata, e riguarda un motivo di profondo dolore per i musulmani, che vedono come tra loro ci si uccida e poi si va a pregare tutti insieme alla stessa ora.
[1] L’aneddoto dice che il cardinal Ballestrero, appartenente alla commissione teologica del Concilio Ecumenico Vaticano II, raccontava di essere intervenuto nella redazione di questo documento che cominciava con “Luctus et angor, gaudium et spes”, cioè “I lutti e le angosce, le gioie e le speranze”, perché l'ordine originale era al contrario del definitivo: allora Ballestrero ricordava di aver detto: “.. ma Sant’Iddio, un documento che comincia così… con i lutti …, giriamola al contrario, mettiamo: Gaudium et spes, Luctus et angor”. Questo era stato un suo contributo al documento della Gaudium et Spes, che è rimasto evidente.
[2] Quando succede, e capita abbastanza frequentemente, che mi chiedano, da parte di coloro che vogliono conoscere e capire, di spiegare nelle comunità cristiane l’Islam, è bene fare prima l’operazione di parlare con un linguaggio comprensibile all'interno della propria tradizione religiosa, per affrontare lo studio e la comprensione dei temi islamici. Poi, dopo un certo percorso, si può anche invitare un musulmano per un confronto sereno e costruttivo. Se anche i musulmani facessero lo stesso, sarebbe davvero una bella cosa: nelle comunità musulmane impostare un’attività che li coinvolga nello spiegare da parte loro, cos’è il cristianesimo, impegnando il massimo possibile di correttezza, questo sarebbe un primo segno di ospitalità molto bello.